|
71. ILLUMINATORI E TORCE SUBACQUEE
Cerchiamo di fare un pò di "luce" nel
vasto mondo degli strumenti per l'illuminazione subacquea.
(testo
rielaborato e corretto da
Marcello Polacchini)
Ormai
nelle immersioni subacquee la torcia o la lampada subacquea sono
diventati strumenti indispensabili, non solo - come è naturale -
per le immersioni notturne, nelle grotte o nei relitti, ma anche per le
immersioni fatte di giorno a profondità superiori a una ventina di
metri, dove soltanto l’impiego di una buona fonte luminosa permette al
subacqueo di non perdere tutta la bellezza dei colori naturali della
flora e della fauna.
Le torce ad uso subacqueo hanno subito
una costante e notevole evoluzione nel corso degli anni e, per capire quale
sia stata questa evoluzione, bisogna fare un salto indietro nel passato.
All’inizio la torcia subacquea veniva utilizzata solo per la pesca
notturna e i primi modelli erano dei fari molto ingombranti, alimentati
con primordiali tipi di batterie per automobili: si trattava di torce
costruite artigianalmente dagli stessi pescatori subacquei, che
impiegarono ottone cromato o rame per costruire un cilindro e vi
applicarono una lente in vetro e guarnizioni in caucciù. In seguito
apparvero diversi modelli fatti di gomma, resistenti agli urti e
completamente stagni anche a profondità abbastanza elevate. Queste prime
torce producevano una luce a cono diffusa, che permetteva di avere un
ampio campo di visibilità. Più tardi le torce cominciarono ad essere
impiegate anche nelle immersioni subacquee ricreative, sia notturne che
diurne e nell’ultima quindicina d’anni c’è stata davvero una notevole
evoluzione delle fonti di luce artificiale ad uso subacqueo, soprattutto
grazie all’apporto tecnico computerizzato.
Le modifiche attuate negli
ultimi anni, più che un’innovazione strutturale, riguardano una
dotazione di accessori più evoluti, come ad esempio accumulatori
ricaricabili al Nichel-Cadmio o al Piombo assorbito, lampadine al
quarzo, alogene, allo Iodio, al Kripton, allo Xeno e ad altri gas nobili
e poi parabole e vetri sempre più sofisticati.
Vediamo
adesso nel dettaglio quali sono i singoli componenti di una torcia
subacquea.
|
Il corpo
Il corpo è il contenitore tubolare,
cilindrico o poligonale, che normalmente viene impugnato dal
subacqueo e ospita internamente il gruppo di alimentazione e
anteriormente la parabola e la lampadina; inoltre sul corpo è
alloggiato il sistema di accensione. I materiali di costruzione
sono dei tecnopolimeri (alcuni sono addizionati, in fase di
stampaggio, a sostanze ausiliarie che ne incrementano i valori
di resistenza meccanica), oppure una lega leggera di alluminio
con trattamento anticorrosione (anticorodal). I corpi più
sofisticati sono ricoperti di termo gomma, che li protegge in
caso di urti, oppure hanno le superfici zigrinate o presagomate
per una presa ottimale anche con i guanti. Il cilindro del corpo
termina con una filettatura dotata di uno o più O-rings di
tenuta su cui si inserisce la porzione anteriore (cioè la testa
illuminante che contiene la parabola e la lampadina).
La testa illuminante
La testa è il sistema anteriore che
contiene gli elementi principali della torcia: la parabola, il
porta lampada, la lampadina e l’oblò e di solito è assicurato al
corpo della torcia da una ghiera (munita di uno più O-rings
all’interno), che assicura la tenuta e, a volte, serve anche da
interruttore di accensione. In alcune torce (specie in quelle da
apnea) la testa è ricoperta da un particolare rivestimento
antiurto in poliuretano, in gomma o in PVC. Qualche esemplare
possiede anche una guarnizione di tenuta supplementare e questo
ulteriore rivestimento è anch’esso stampato in plastica o in
ABS. Il corpo illuminante ha frontalmente una lente piana spessa
in policarbonato trasparente, in vetro o in cristallo temperato
(detta oblò), che è annegata direttamente e indissolubilmente al
supporto di tenuta, oppure è avvitata con il solito O-ring di
tenuta. L’oblò deve resistere a graffi e rigature marcate e deve
essere di buona qualità ottica.
La parabola
La parabola è quella parte della torcia
alloggiata nella testa illuminante che permette la proiezione
del cono di luce. Si tratta di un corpo illuminante (di solito
metallico) con forma appunto paraboloide, più o meno aperta,
adatta per generare fasci di luce larghi e diffusi oppure più
concentrati (spot). Per l’uso subacqueo deve avere un preciso punto di
fuoco, un altissimo indice di riflessione, un’inalterabilità nel
tempo e un’elevata termoresistenza.
Le parabole sono argentee,
lisce o dotate di micro sfaccettature (cd. multimirror), per
catturare e riflettere ogni particella di luminosità e qualcuna
è progettata al computer per esaltare al massimo la qualità
della luce diffusa. |


 |

 |
La lampadina
La lampadina è sorretta da una piccola
molla e da un supporto porta lampada. Essa è il “cuore” della
torcia e ha un voltaggio leggermente inferiore rispetto alla
tensione di corrente erogata dal pacco batterie (ad es. nel caso
di una torcia con 3 pile da 1,5 Volt - pari a 4,5 Volt totali -
la lampadina è da 4 Volt). Questa precauzione del survoltaggio
consente di ottenere un’intensità luminosa superiore senza
interferire troppo con la durata della lampadina.
Come ben sappiamo esistono diversi tipi di
luci e la loro differenza principale è il colore o, meglio, la
temperatura del colore, che si misura in gradi Kelvin (°K).
Infatti, ogni materiale sia solido che gassoso, se portato
all’incandescenza, emette un particolare colore.
Inizialmente le lampadine ad incandescenza
erano semplicemente al quarzo, cioè erano dei tubetti di quarzo
contenenti al loro interno la vecchia classica resistenza
elettrica in tungsteno (un metallo che emette luce a 3.000 gradi Kelvin),
direttamente a contatto con l’atmosfera dell’ambiente e riparata
meccanicamente dal tubo di quarzo. La normale lampadina ad
incandescenza ha certamente il più basso costo rispetto a
qualsiasi altra tecnologia di illuminazione, ma una parte
dell’energia elettrica viene sprecata e dissipata in forma di
calore, piuttosto che di luce. Così sono nate le lampade
alogene, che sfruttano una miscela di gas inerti per ridurre
l’evaporazione del filamento in tungsteno. In questo modo il
filamento può essere portato ad una temperatura più elevata e,
di conseguenza, queste lampade raggiungono i 3.200-3.400 °K e danno
una maggiore luce.
Oggi dunque le lampadine sono quasi tutte
alogene, cioè sono lampade che impiegano un filamento in
tungsteno reso incandescente all’interno di un’atmosfera di gas
alogeni contenuti in una piccola ampolla di quarzo. Quella
alogena è una bella luce, con un’ottima resa cromatica, lunga
durata e grande resa luminosa, conseguenza della reazione
chimico/fisica del Tungsteno/alogeno che mantiene il filamento
integro e il bulbo pulito. Rispetto alle lampadine tradizionali
a filamento incandescente, le alogene offrono un’efficienza
luminosa tripla e una luce fredda e bianchissima (dato che hanno
una temperatura di colore più elevata). |
|
Il loro funzionamento è
il seguente: la speciale ampolla ha un filamento interno in
Tungsteno che va progressivamente ad esaurirsi e che è posto
all’interno di un bulbo di quarzo puro contenente un’atmosfera
di gas alogeno (di solito Iodio allo stato gassoso, oppure Kripton o Xeno). Durante il passaggio della corrente il
filamento si disgrega liberando atomi di Tungsteno che si
raffreddano a contatto con il quarzo. In questo modo avviene una
reazione chimica con il vapore di Iodio che forma ioduro di
tungsteno. In pratica dal filamento di Tungsteno evaporano degli
atomi che si combinano con quelli dei gas alogeni e si forma
così un composto gassoso che ricade sul filamento incandescente, ridepositando gli atomi di
Tungsteno. Gli atomi dei gas alogeni
così sono di nuovo liberi di ricombinarsi con gli atomi di
Tungsteno. In questo ciclo, detto di "rigenerazione", sta il
segreto della lunga durata di questo particolare tipo di lampade
ad incandescenza.
Le lampade alogene oggi sono sicuramente
le più comuni che possiamo trovare in commercio e hanno una
qualità di illuminazione eccezionale. Vi sono lampade di
moltissimi tipi e potenze. In generale per le immersioni
singole ricreative o avanzate ma senza esigenze particolari 50 W con
un’autonomia di 50/60 minuti sono più che sufficienti.
Ovviamente 100 W sono meglio ma, aumentando la potenza, si
riduce la durata e aumenta il costo per avere batterie più
capienti, oltre naturalmente ad un maggiore peso ed ingombro
(pensate alla famosa, intramontabile Vega 100 della Technisub...).
Recentemente nelle lampade alogene al posto dello
Iodio sono sati impiegati altri gas alogeni, come il Kripton o
lo Xeno, che danno una luce molto più bianca (circa 3.500 °K) e
permettono una maggiore durata del filamento di Tungsteno. |

 |


 |
Negli ultimi anni hanno preso sempre più
piede le lampade a diodi luminosi o "LED" (Light Emitting Diode =
diodo ad emissione luminosa). Il funzionamento del LED si basa
sul fenomeno detto "elettroluminescenza", dovuto all’emissione
di fotoni: questi dispositivi sfruttano le proprietà ottiche di
alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni a partire
dalla ricombinazione di coppie elettrone-lacuna. Il
funzionamento è il seguente: gli elettroni e le lacune vengono
iniettati in una zona di ricombinazione attraverso due regioni
del diodo “drogate” con impurità di tipo diverso. Il colore
della radiazione emessa è definito dalla distanza in energia tra
i livelli energetici di elettroni e lacune. I LED sono formati
da GaAs (arseniuro di Gallio) GaP (fosfuro di Gallio), GaAsP
(fosfuro arseniuro di Gallio), SiC (carburo di Silicio) e GaInN
(nitruro di Gallio e Indio). La scelta dei diversi
semiconduttori impiegati determina la lunghezza d’onda
dell’emissione di picco dei fotoni, l’efficienza nella
conversione elettro-ottica e quindi l’intensità luminosa in
uscita.
I vantaggi dei LED dal punto di vista
illuminotecnico sono: lunga durata di funzionamento (i LED ad alta
emissione arrivano a circa 50000 ore, gli altri possono
arrivare persino a 100000 ore), elevato rendimento (se
paragonato a lampade ad incandescenza e alogene), luce bianca
e pulita
perché priva di componenti infrarosse o ultraviolette,
insensibilità a umidità e vibrazioni, elevata affidabilità e
basso consumo. Questo ne fa sicuramente una soluzione molto
vantaggiosa nel caso di luci di backup e per le immersioni in
cui si richiede una grande autonomia, come quelle in grotta. Lo
svantaggio è che la luce prodotta ha un temperatura colore tale
che di giorno non è assolutamente utile nelle applicazioni
subacquee; mentre di notte il fascio azzurrino prodotto dalla
scarica di fotoni produce una luce molto penetrante.
Per
evitare la dispersione di calore e di energia tipici delle
lampadine ad incandescenza oggi nella subacquea vengono
impiegate anche sorgenti di luce fredda come le lampade "HID" (High Intensity Discharge lamps), che danno una
luce più visibile per la stessa quantità di energia elettrica in
ingresso. Si tratta di lampadine senza filamento metallico. Due
elettrodi immersi in un’atmosfera di xeno sono collegati con i
due poli del circuito elettrico. La scarica di elettroni tra i
due produce una luce molto intensa, circa il doppio di quella
delle lampade alogene, ed estremamente bianca (tale da apparire
persino blu). Mancando il filamento, queste lampadine hanno una
durata del doppio superiore rispetto a quelle convenzionali e
consumano il 70% in meno. Vanno regolate con una centralina
elettronica per evitare il danneggiamento in seguito a sbalzi di
tensione.
Il rendimento delle lampadine HID è molto
più alto di quello delle lampade alogene e delle Xenophot; anche
la resa luminosa è molto alta: una HID di 35W da 3500 lumen è
pari a 100 lumen/watt, mentre per le alogene non survoltate (che
durano circa 2000 ore) si arriva intorno ai 25 lumen/watt; le
alogene survoltate (che durano circa 50 ore), invece si
attestano intorno ai 35 lumen/watt. |
Pertanto
le lampade HID hanno una resa all’incirca
4 volte superiore e quindi, a parità di batteria, consentono una
autonomia quadrupla. Di contro le lampade HID presentano alcuni svantaggi: prima
di tutto il costo, dato che solo la lampadina può costare anche più di
100-120 euro e la centralina elettronica si aggira sui 200 euro e poi la
loro sensibilità all’umidità. E’ vero che si risparmia sulla batteria,
ma le tensioni in gioco sono dell’ordine di 6.000-30.000 Volt perciò il
sistema è sensibilissimo all’umidità: basta una piccolissima quantità di
acqua condensata per generare archi voltaici che provocano danni
irreparabili alla parte elettronica, con danni economici notevoli.

 |
L’interruttore
Insieme a eventuali lamine di contatto
l’interruttore è il mezzo che consente l’accensione o lo
spegnimento della torcia subacquea. Deve essere pratico,
immediato, facilmente individuabile al tatto e azionabile anche
con guanti spessi. Può essere di due tipi: magnetico se il
contatto si aziona tramite un cursore a calamita esterno; oppure
meccanico se sono presenti dei leveraggi metallici che chiudono
e aprono il circuito elettrico.
Il sistema magnetico (reed) è andato
piuttosto in disuso dati i costi abbastanza elevati dei
componenti interni. Il contatto reed è un interruttore a lamina
(normalmente aperto) che si chiude in presenza di un campo
magnetico. Nella forma più semplice è costituito da due
lamine, realizzate con materiale ferromagnetico (una lega di
ferro-nichel), parzialmente sovrapposte e separate tra loro di
qualche decimo di millimetro. Sulle lamine contrapposte sono
riportati dei contatti (generalmente in oro diffuso). Le lamine
vengono sigillate all’interno di un piccolo contenitore
sottovuoto di vetro riempito di gas inerte (azoto o argon). Le
estremità delle lamine (opposte ai contatti) fuoriescono dal
contenitore e costituiscono i terminali del contatto, azionato
dal cursore magnetico che scorre al di sopra del sistema. In
presenza di un campo magnetico le lamine diventano sede di
flusso magnetico e sulle estremità si formano poli di segno
opposto che tendono ad attrarsi. Se il campo magnetico è
sufficientemente forte (100-200 amperspire), la forza
d’attrazione vince la resistenza a flessione delle lamine
metalliche e queste attraendosi chiuderanno il contatto. Il
vantaggio di questo tipo di interruttore è che non ci sono
aperture supplementari sul corpo della torcia; lo svantaggio è
che le lamelle possono incollarsi o non fare contatto.
Il sistema di accensione meccanico è il
più comune e oramai ha raggiunto livelli di affidabilità totali.
Per accedere ai meccanismi c’è bisogno che il corpo della torcia
sia forato e protetto dalle infiltrazioni d’acqua con un O-ring
di tenuta. L’alberino di trasmissione potrà essere comandato da
diversi sistemi: a rotazione tramite un pomello, a slitta, o a
cursore. Uno speciale interruttore equipaggia alcune micro torce
ed è definito “a vite”: in pratica è la stessa ghiera basculante
che, opportunamente allentata, permette il contatto d’accensione
che si effettua tramite una pressione anteriore (normalmente si
sfrutta quella presente ad una certa quota d’esercizio
subacqueo).
In quasi tutti i modelli è presente una
sicura di accensione: si tratta di un blocco meccanico
sull’interruttore che impedisce, più che altro, l’accensione
accidentale della torcia durante i periodi di inutilizzo in
acqua e soprattutto fuori durante il trasporto nel borsone da
sub. |
|
Il sistema di alimentazione
L’alimentazione della torcia è fornita da
diverse pile usa e getta o da accumulatori (batterie
ricaricabili). Per limitare il peso e le dimensioni della torcia
ci sono vari sistemi: normalmente esistono degli alloggiamenti
estraibili per il pacco batterie oppure c’è una predisposizione
diretta per le batterie nel corpo della torcia. Le pile possono
essere mini stilo (AAA), stilo (AA) o mezze torce (C). Il
voltaggio è da 1,5 volt cadauna. Le pile consigliabili sono
quelle alcaline, che offrono una qualità di energia ottima,
prolungata al massimo per quasi tutta la loro vita e senza un
esagerato decadimento progressivo della tensione elettrica, ma
con una caduta netta della tensione un attimo prima di esaurirsi
completamente. Un’alternativa un pò più costosa al momento
dell’acquisto è un pacco batterie composto da elementi
ricaricabili (accumulatori). In questo caso va controllato il
voltaggio compatibile (solitamente è lievemente inferiore) e la
qualità della composizione interna, dato che le batterie al
nichel cadmio soffrono dell’effetto memoria, perciò se non
vengono ricaricate partendo dall’accumulatore completamente
scarico perdono la proprietà di accumulo di energia.
Il cinghiolo di
sicurezza
In tutte le torce è presente un sistema di
trattenuta denominato cinghiolo: si tratta generalmente di una
fettuccia di caucciù, di gomma, di tessuto di nylon o di
plastica morbida che vincola il corpo della torcia in genere
tramite un anello terminale. Le caratteristiche fondamentali che
deve possedere un buon cinghiolo sono l’adattabilità al polso
del subacqueo, la possibilità di regolazione continua e la
robustezza. La torcia è generalmente assicurata al polso
oppure a un D-ring del gav e deve essere facilmente
individuabile e afferrabile, a volte adoperando solamente la
rotazione del polso. |

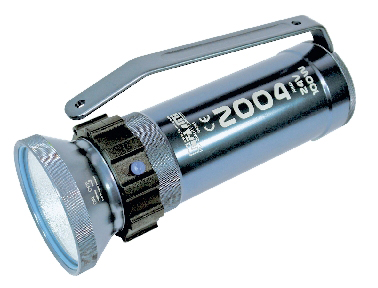 |
Le modifiche e le elaborazioni artigianali
Molte sono le modifiche che è possibile effettuare
artigianalmente alla propria torcia subacquea. Ad esempio il corpo della
torcia può essere rivestito di una guaina di neoprene per proteggerlo,
facendo però attenzione a non ostacolare il flusso luminoso. In tante
torce che non hanno una lampadina performante, si può sostituire la
lampadina originale con un bulbo alogeno o allo xeno. Il pacco batterie
può essere trasformato con degli elementi ricaricabili. Il lacciolo si
può sostituire in infiniti modi, qualità e modelli. Insomma… la fantasia
del subacqueo in questo campo non conosce limiti!


|
La manutenzione della torcia subacquea
Come per il resto dell’attrezzatura
subacquea, anche le torce devono essere risciacquate con
abbondante acqua dolce negli interstizi, sulle parti meccaniche
in movimento e sulle sedi di congiunzione dei diversi pezzi, che
rappresentano i punti critici in cui normalmente rimane la
salsedine. Spesso non basta solo lavare la torcia, soprattutto
se durante il trasporto si è asciugata e incrostata, e si deve
lasciarla a bagno per un po’ di tempo; meglio se in acqua
corrente. Non bisogna mai smontare la torcia prima che sia
completamente asciutta, perché qualche gocciolina di acqua
potrebbe infiltrarsi nei meccanismi o nei circuiti elettrici e
mandarla in cortocircuito. Per rimuovere eventuali detriti che
potrebbero alterare l’integrità delle guarnizioni O-ring occorre
utilizzare un panno asciutto che non rilasci peletti oppure un
cotton fioc.
Quando la torcia non viene usata per un lungo
periodo, è meglio smontare tutti i componenti, pulirli
singolarmente e lubrificare con un velo di grasso al silicone
quelli che necessitano di tale trattamento (O-ring della ghiera
e dell’interruttore). Durante la fase di smontaggio della torcia
o in caso di sostituzione della lampadina, è indispensabile
evitare di toccare con le mani nude la parabola e soprattutto la
lampadina: nel primo caso le particelle di grasso presenti sulla
pelle potrebbero sporcare la parabola e quindi creare ombre,
aloni e opacità fastidiose durante l’uso e nel secondo caso si
può danneggiare seriamente il delicatissimo bulbo di cristallo.
L’oblò della testa illuminante deve sempre essere pulito e
conservato trasparente, perché la sporcizia affievolisce
qualsiasi lampadina sia essa standard, alogena o allo xeno. Un
intervento consigliabile è sempre quello di rimuovere le
batterie nel caso non si utilizzi la torcia per diverso tempo:
la possibilità che perdano acido non è remota e l’operazione di
togliere le batterie salva a priori gli elementi interni.
Nel
caso delle batterie ricaricabili il consiglio è quello di
controllare periodicamente lo stato di carica: una volta ogni
tanto la torcia va accesa e va lasciata scaricare completamente
in un catino d’acqua (per evitare che la lampadina si
surriscaldi ed esploda). Così facendo gli accumulatori non si
danneggeranno e manterranno per molto tempo stabili le loro
proprietà.
Il cinghiolo dovrà essere controllato ogni tanto e
dovrà essere integro e privo di screpolature: in caso di lesioni
è meglio sostituirlo completamente. |
|
Alcuni consigli per scegliere una
torcia subacquea
La torcia subacquea dovrebbe essere
innanzi tutto di dimensioni contenute, tali da non impacciare il
movimento del subacqueo in acqua e il trasporto. Esistono in
commercio delle torce con il pacco batterie separato,
contenuto all'interno di un cilindro in alluminio o in darlin (canister) che
viene attaccato alla bombola o al gav. Questo sistema ha il vantaggio di
consentire al subacqueo di tenere in mano sola la testa
illuminante, che è collegata al pacco batterie con un cavo
liscio o spiralato e che ha un ingombro e un peso molto
modesto. Alcune torce hanno il cavo di collegamento al pacco
batterie con un cavo a contatti bagnati, che si può
connettere/disconnettere anche sott'acqua, in modo da poter
cambiare durante l'immersione il pacco batterie quando è
esaurito.
Una caratteristica
molto importante da prendere in
considerazione nella scelta di una torcia è l’ampiezza del
fascio luminoso. Molte delle piccole torce in commercio derivano
dai modelli da pesca subacquea, dove l’esigenza è quella di
abbagliare il pesce e riuscire a illuminare, con una luce
concentrata e brillante, il fondo di una tana; in questo caso il
fascio luminoso dovrà essere abbastanza concentrato (spot con un
angolo di 10, 8 o addirittura 6 gradi) e non
diffuso a cono esteso. Chi si immerge con le bombole, invece,
di solito ha esigenze totalmente diverse, perché deve avere anche a breve
distanza una vasta porzione di parete illuminata. Nelle
immersioni speleo o nei relitti, invece, è meglio utilizzare una
parabola che produca un cono di luce molto stretto e
concentrato.
Generalmente
soltanto i fari dispongono di un
fascio di luce sufficientemente ampio e i migliori in commercio
oramai hanno
tutti caratteristiche tecniche simili. Pochissimi modelli di
torce e fari hanno il fascio luminoso regolabile dall’esterno,
però occorre fare attenzione ad adattare il fascio luminoso alle
proprie esigenze allargandolo o stringendolo, perché
inevitabilmente si creerebbero delle grosse zone d’ombra. Lo
scopo della regolazione del fascio non è tanto quello di variare
l’angolo del fascio di luce (più o meno aperto), quanto quello di
concentrare e "pulire" la luce, ottenendo sempre una centratura
ottimale della lampadina rispetto alla parabola riflettente.
|


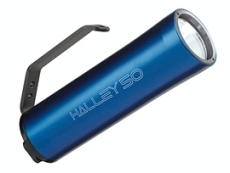 |
|

 |
Chi usa la torcia frequentemente e durante
tanti mesi dell’anno è meglio che si orienti verso gli
accumulatori ricaricabili, utili per diverse centinaia di cicli di
carica/scarica completa. Sul mercato esistono anche delle nuovissime pile
(al litio, all’idrogeno, eccetera…) che non hanno l’effetto
memoria.
Le torce più grosse o i fari, in genere
sono disponibili anche in versione con accumulatori ricaricabili
al Nichel-Cadmio o al Piombo assorbito. Un sistema di questo
tipo ha il vantaggio di poter essere ricaricato prima di ogni
immersione in modo da poter disporre della totale autonomia,
mentre con le pile non si è in grado di conoscere esattamente lo
stato di carica, a meno di non sostituirle ogni volta che ci si
immerge.
Purtroppo i modelli con batterie
ricaricabili presentano alcuni difetti: sono molto costosi,
hanno una minore autonomia rispetto alle pile a secco e,
naturalmente, occorre disporre di una presa elettrica per la
ricarica e del relativo numero di ore necessario per
effettuarla.
Gli
interruttori di cui torce e fari sono
dotati possono essere meccanici oppure magnetici. Nel primo caso
una leva o una manopola agiscono, tramite un alberino passante,
sull'interruttore del circuito. Nel secondo non ci sono, invece,
perni passanti, dato che un cursore esterno sposta un magnete
che agisce sulle lamelle di un piccolo reed (il contatto
reed è
un interruttore a lamina, normalmente aperto, che si chiude in
presenza di un campo magnetico). Entrambi i sistemi funzionano bene, se ben
progettati, ma, in genere, con grossi amperaggi si preferiscono
i sistemi meccanici, per evitare l’incollaggio delle lamelle del
reed. In ogni caso l’interruttore dovrà essere abbastanza in
rilievo e con una superficie ampia per poterlo azionare anche in
condizioni difficili semplicemente con un dito e con i guanti; ma al contempo
non dovrà essere troppo morbido o facile all’accensione
accidentale (è utile che ci sia una sicura antiaccensione).
Le caratteristiche da considerare per
l’acquisto di una torcia subacquea
Una buona torcia è il più bel regalo che
possiamo fare a noi stessi per godere maggiormente ogni
immersione, sia notturna che diurna. Meglio investire, quindi,
una certa cifra, tanto più che i modelli migliori, se trattati
con cura, sono in grado di durare per parecchio tempo. Prima
dell’acquisto è meglio confrontare l’angolo d’illuminazione,
l’intensità della luce e la pulizia della zona illuminata, che
deve essere assolutamente priva di aloni e zone d’ombra. Spesso,
queste sono dovute alla lampadina non perfettamente centrata
rispetto alla parabola. La scelta tra un modello con pile
monouso oppure ricaricabili dipende da quanto si pensa di
utilizzarlo. Occorre però ricordare che una batteria
ricaricabile necessita di una particolare manutenzione
stagionale.
Per l’esplorazione subacquea vanno
impiegati degli illuminatori veri e propri, che nei modelli più
piccoli da 20 e 50 W forniscono una luce stupenda ed hanno
dimensioni e costi molto accessibili. Bisogna però fare
attenzione all’autonomia, perché potrebbe risultare
insufficiente per un’immersione notturna (certe torce con
lampadina alogena non superano i 40-45 minuti di autonomia). Una
lunga durata è assicurata dalle torce che al posto della
tradizionale lampadina hanno una serie di diodi luminosi (LED),
ma, come già detto sopra, la loro luce azzurrina si rivela
assolutamente insufficiente di giorno e non restituisce
all’occhio la naturalezza dei colori. Per le riprese filmate
infine, non c’è che l’imbarazzo della scelta, con potenze che
arrivano anche a 800-1.000 W, ma con prezzi, pesi e ingombri di
tutto rispetto. |
|
Le 3 categorie
di illuminatori subacquei
a) HID
Le
lampadine HID (acronimo che sta per "High Intensity Discharge")
sono lampadine senza filamento metallico, che hanno gli
elettrodi immersi in un’atmosfera di Xeno e sono collegati con i
due poli del circuito elettrico. La scarica di elettroni tra i
due poli produce una luce bianchissima molto intensa, circa
il doppio di quella delle lampade alogene. Mancando il
filamento, queste lampadine hanno una durata superiore a
quelle convenzionali e consumano meno energia. Funzionano
con una centralina elettronica (ballast).
Il rendimento delle lampadine HID è molto più alto delle lampade
alogene ed anche la resa luminosa è molto alta: una HID
di 35 watt da 3.500 lumen ha una resa di 100 lumen/watt, mentre
per le alogene convenzionali siamo intorno ai 25 lumen/watt;
invece le alogene survoltate, del tipo HLX si attestano intorno
ai 35 lumen/watt.
La temperatura
colore espressa in gradi Kelvin varia dai 4.500 gradi in su.
Si può dire che le HID hanno una resa tre volte superiore
e quindi, a parità di batteria, consentono un’autonomia
tripla.
b) ALOGENE
La lampada alogena è una particolare lampadina a incandescenza
che ha al suo interno un filamento (tipicamente in Tungtsteno o
simili) e che emette luce secondo il principio
dell'incandescenza, applicando direttamente ai poli una
tensione. Le alogene sono sicuramente le lampade più comuni che
possiamo trovare in commercio e ve ne sono di moltissimi tipi e
potenze; le più usate per l’uso subacqueo sono del tipo
Xenophot, a volte survoltate per dare una maggiore intensità
alla luce. In generale per immersioni ricreative/avanzate senza
esigenze particolari 50 W sono lo standard, mentre
aumentando la potenza della lampada si riduce la durata, e di
conseguenza avremmo bisogno di batterie più potenti e
ingombranti.
La lampada alogena non ha bisogno di particolari “accortezze
elettroniche” per poter funzionare e la sua efficienza luminosa
è intorno ai 35 lumen/watt, però scalda molto e assorbe molta
corrente.
La temperatura colore di queste lampade si attesta intorno ai
3.200 gradi Kelvin.
c) LED
Il termine "LED" è un acronimo che sta per "Light Emitting Diode",
ovvero "diodo che emette luce". I LED sono sempre più utilizzati
in ambito illuminotecnico in sostituzione di alcune sorgenti di
luce tradizionali. Nei modelli di ultima generazione per uso
professionale la resa luminosa si attesta intorno ai 120
lumen/watt, come minimo.
Il loro utilizzo
in ambito subacqueo li rende una sorgente di tutto rispetto con
la sua efficienza pari a 90 lumen/watt. Come termine di paragone
basti pensare che una lampada a incandescenza ha un'efficienza
luminosa di circa 20 lumen/watt, mentre una lampada alogena di
25-35 lumen/watt ed una fluorescente lineare fino a 104
lumen/watt. Un loro limite
nell'illuminazione è che le loro caratteristiche di emissione
e durata sono fortemente condizionate dalle caratteristiche di
alimentazione e dissipazione. I LED, infatti, hanno bisogno
di corrente stabile e di un’ottima dissipazione e al contrario
di altre fonti luminose il calore viene generato nella parte
posteriore del diodo.
Teniamo presente però che oggi sul mercato sono reperibili anche
LED di ultima generazione con temperatura colore
dai 3.200 ai 6.500-7.000 gradi Kelvin. La loro resa luminosa e
cromatica è notevole e
consentono ottime autonomie.
Per
un maggiore approfondimento sulla tecnologia a LED e per la
risposta alle
domande più
frequenti in tema di illuminazione subacquea, consiglio la
lettura di un interessante articolo scritto da Massimo Carello (www.torcesub.it),
unico rivenditore in Italia delle lampade subacquee tedesche
FWT-Schulz (http://lampen.fwt-schulz.com/lampen/)
che offre un'utile guida alla scelta e all'acquisto di una
torcia subacquea:
http://www.marpola.it/TecnicaeMedicina/115.htm
|

 |

 |
Un confronto tra le varie tipologie di
lampade
Parlando
di resa luminosa dei vari tipi di lampade, in ogni caso è
molto difficile paragonare la resa luminosa di illuminatori
diversi, perché questa è influenzata da tanti parametri. La
quantità dei Watt non è significativa, perché i Watt indicano
il consumo elettrico, ma non la resa di luce.
Ogni sistema illuminante ha una propria
resa luminosa (Watt impiegati / luce emessa), chiamato “rapporto
di efficienza”.
Per fare qualche esempio del rapporto
di efficienza possiamo dire che la lampada a incandescenza
normale rende circa il 2% in luce della potenza assorbita, con
l’alogena saliamo al 3-4%, mentre per i LED o le HID siamo tra
il 15% e il 18% (valori indicativi).
Quindi, a parità di potenza (cioè Watt
assorbiti), le lampadine a incandescenza emettono luce in
quantità minore rispetto alle altre, mentre le lampade HID e
LED sono quelle che emettono più luce.
Ma se è vero che a parità di potenza
assorbita le lampade a LED e HID emettono quantità maggiori di luce, è
anche vero che la luce emessa è di diverso "colore".
Per dare un'idea di cosa significa
"colore" possiamo dire ad esempio che una barra di ferro non
emette luce, ma se viene riscaldata le sue molecole inizieranno
a emettere onde elettromagnetiche. Queste all’inizio non sono
visibili all’occhio umano (sono infrarossi) ma a mano a mano che
aumenta la temperatura le onde emesse aumenteranno la loro
frequenza entrando nello spettro visibile compreso tra
l’infrarosso e l’ultravioletto. Questo
per dire che la luce emessa non è dello stesso colore ma ogni
fonte riesce a emettere luce a una determinata temperatura
espressa in gradi Kelvin. Abbiamo cosi i due estremi, quello
infrarosso ossia una luce a 1.800 gradi Kelvin (temperatura
bassa) e quello ultravioletto a circa 16.000 gradi Kelvin
(temperatura elevata).
Paradossalmente psicologicamente
avvertiamo la luce più vicina al rosso come più "calda", anche
se la sua temperatura è più "fredda" e avvertiamo come luce
"fredda" quella vicino all’ultravioletto, anche se la sua
temperatura è "calda".
Le lampade a incandescenza e le alogene
sono a luce calda con una temperatura intorno ai 2.000/3.000
gradi Kelvin; invece le lampade
HID e a LED emettono luce sopra i 4.000/5.000 gradi Kelvin. |
|
Per dare un’idea di cosa significa "gradi
Kelvin" possiamo considerare che la luce solare a mezzogiorno
è intorno ai 5.400 gradi Kelvin. Quindi le lampade a LED e le
HID sono le più vicine alla luce naturale del sole e la
luce naturale deve essere il riferimento. Non occorre più luce
possibile, occorre la luce giusta!
In ogni caso, di giorno tutte le lampade
a LED e le HID hanno una resa ai nostri occhi bassissima,
perchè emettono luce più o meno della stessa qualità di quella
dell’ambiente circostante.
Sarebbe come scrivere con un pennarello
bianco su una lavagna bianca: per quanto grosso sia il tratto i
nostri cocchi non vedono il bianco sul bianco. Se al contrario
la lavagna è nera, ecco che il pennarello bianco ha una grande
resa. Durante un'immersione notturna per esempio le lampade HID
e quelle a LED sono fantastiche e a parità di potenza assorbita
superano nettamente le lampade alogene.
Di giorno le lampade alogene sono le più
indicate, in quanto fanno una luce diversa, più
calda della luce del giorno, ragion per cui anche se non
emettono la stessa quantità di luce questa risulta più
visibile. Per continuare l'esempio della lavagna, sarebbe
come scrivere con un pennarello giallo su una lavagna bianca: ai
nostri occhi il giallo è più visibile del bianco.
La lampada HID da 21 W emette 1.500 lumen,
come un'alogena da 50 W survoltata (come ad esempio
la sempre ottima "Alulight 50" prodotta dalla Technisub)Per indicare la
"luminosità" i Lumen sono più indicativi dei Watt, che
indicano il consumo ma non la luminosità, per cui non possono
essere usati per misurare le HID e le LED, che hanno una resa Lm/W
molto superiore alle alogene.
Tuttavia, nemmeno i Lumen sono
particolarmente indicativi dell'efficienza di una fonte
luminosa, perché ad esempio ci sono lampade a LED che emettono
moltissimi Lumen, ma non hanno la penetrazione delle lampade HID.
Perciò, per misurare la "penetrazione" sono importanti i Lux
emessi dalla lampada.
Per
fare un esempio, in confronto a una lampada a LED, sia pure ottima, la HID
emana 3.500 Lux a 3 metri contro 2.500 Lux. La lampada alogena,
invece, si colloca molto al di sotto della HID, inoltre, a
parità di Lumen, l'alogena consuma 50 W e la HID solo 21 W.
Quindi, una batteria con la lampada HID dura più del doppio.
Certamente una lampada HID da 21 W "DIR Style" (cioè con testa
separata con maniglia Goodman, collegata al canister delle
batterie con un cavo) costa parecchio, ma è
assolutamente di un altro livello, rispetto, per esempio ad
un’alogena molto diffusa come la Fa&Mi da 50 W.
Riguardo ai LED poi, bisogna distinguere
i prodotti di prima generazione da quelli usciti sul mercato più
di recente. Per la subacquea tecnica oggi è ancora preferibile una
lampada HID, ma bisogna fare attenzione, perché al massimo
entro il 2013 usciranno dei LED con prestazioni migliori
delle attuali lampade HID da 21 Watt.
Comunque non ci sono differenze
abissali, tra la luce emessa da una HID 21 W e quella di un’alogena da 50 W. Se una HID
21 W eroga 1.500 Lumen come una 50 W alogena, è ovvio che la
luce della prima sarà un pò più penetrante, soprattutto se si riesce
a stringere molto il fascio, ma più o meno la quantità di
luce erogata è la stessa. La differenza oltre al fuoco, è
soprattutto nella durata e nel colore della luce.
Una 50 W alogena spot fa la luce giusta, come intensità, ma il
problema è la durata limitata (massimo 50-55 minuti). Invece la HID 21
W risolve questo problema, a pari o superiore intensità di luce.
La LED, infine, è una via di mezzo: se con una LED si vuole
superare l'intensità di una 50 W alogena o di una 21 W HID, le
batterie consumano troppo, il calore dissipato è elevato e
attualmente c’è un problema ottico nello stringere il fascio
come in una HID. Perciò, al momento attuale, ancora non è
facile superare le prestazioni delle HID senza perdere in durata.
La tecnologia però, come già detto, si sta evolvendo molto
velocemente. Bisogna seguirla. |
Torna all'inizio della pagina |
